Lo spaccato della Martina degli anni 70-80 che grazie a un gruppo di giovani contagiati da uno stile di vita quasi “on the road†rendevano la città meno provinciale e più evoluta nel costume
Â
Â
Â
C’era una volta un gruppo di amici, nome in codice “Frequenza Radio Vitelloniâ€, che si riuniva nel 2014 (di domenica mattina) per dare corpo ad un progetto che li teneva uniti nello stesso vortice di passione della (lontana) gioventù: la musica rock, echi lontani di maggio franco-martinese, l’estetica della cultura giovanile degli anni 60-70 che non potevano/volevano scrollarsi di dosso.
Gianni Trono, Tonio Semeraro, Agostino Convertino e Franchetto Russano, il vitellone che un destino più cinico che baro ha strappato alla vita. Uomo di modi raffinati, artista e pittore, docente d’arte e grafico professionista, Franchetto Russano emanava un fascino magnetico e non solo per la sua bellezza fisica. I 4-vitelloni-4 stavano lavorando a un progetto musicale che ripercorreva il successo ottenuto qualche anno prima col “Rave 56â€, mega-festa rock per vitelloni immatricolati nel 1956, da offrire anche alla generazione della musica liquida, i nuovi camalli tecnologici che scaricano la musica da internet. La scomparsa di Franchetto ci ha colti in mezzo al guado dell’organizzazione dell’happening ma siamo pronti a saldare il debito con lui la sera del 3 luglio. Nelle vicende di oltre un decennio qui riportate Franchetto Russano è stato testimone e protagonista diretto ma sempre col suo stile defilato ed elegante. Il suo è stato un contributo di sostanza ma anche di grande equilibrio in una fase in cui gli eccessi rappresentavano, per forza di cose, la norma.Â
L’imprinting della storia è inconfondibile: la Martina degli anni 70-80 che grazie ad un gruppo di giovani contagiati da uno stile di vita quasi “on the road†rendevano la città meno provinciale e più evoluta nel costume. Un’avanguardia la chiameremmo oggi. Certo, la sera ci ritiravamo tutti alle case ma nel resto della giornata pulsava forte la cultura beat di Jack Kerouac, Allen Ginsberg, William Burroughs e Gregory Corso; la controcultura underground fluiva, brulicante di novità e una certa anarchia alla buona, attraverso una fitta rete di contatti di gente che andava&veniva; in autostop da e verso l’Europa (non avevamo mica facebook, whatsapp o blablacar). Il collante di tutto erano il rock (progressive), il sesso della liberazione dai tabù e cannoni dalle dimensioni di un filone pane&mortadella;….
Le musiche sperimentali irrompevano dal nord-Europa sulle orme di Terry Riley, Karlheinz Stockhausen (nome che molti, ignari, oggi utilizzano per evitare l’imbarazzo di una parolaccia), Popol Vuh e Tangerine Dream. Epicentro indiscusso di quel momento storico fu il Giangià Club. All’epoca, i giovani martinesi si riunivano, in regime di semi-clandestinità , in monolocali del centro storico che rappresentavano poli di aggregazione bellissima: feste da ballo, luci psichedeliche con lampadine pittate a colori col ducotone (non avevamo i led), sesso di contrabbando e soprattutto tanta musica, dal vivo o riprodotta dal famigerato Stereo di Selezione (Rider’s Digest, popolare edizione italiana dell’omonimo magazine americano che sonorizzò le case di milioni di italiani – 60.000 lire in dodici comode rate da 5.000 e si entrava nel prodigioso mondo della stereofonia). Le ragazze, all’epoca, non riuscivano a sforare nemmeno le dieci di sera - roba che Cenerentola, col suo rientro a mezzanotte, al confronto appariva una spregiudicata messalina. Ebbene, fra tutti i locali di Martina, il Giangià , situato in uno strepitoso dislivello SÅtta Jezze, era il migliore: un rettangolo di circa 40 metri quadrati che assomigliava dannatamente, stretto e lungo com’era, ai micro jazz club dell’epoca d’oro di New York City. Mura spesse e antiche, che comprimevano il suono all’interno, quando si apriva la porta del club si veniva investiti da un torrente di musica in piena. L’ambiente era dotato di un divisorio di compensato oltre il quale giaceva lui….un orribile divano di velluto giallo oro, destinato essenzialmente all’accoppiamento, gonfio dell’umidità ambientale impregnata di patchouli (essenza asiatica che marcava, a livello olfattivo, il popolo underground dell’epoca). Sulle pareti un’anarchia stilistica e cromatica che avrei volentieri scorticato per esporla al MoMa di NYC. Quando c’erano gli scioperi a scuola (per la maggior parte ideologicamente fasulli) il Giangià si riempiva a un punto tale che si cominciava a pomiciare con una ragazza e si finiva con la sua compagna di banco. Ma il pezzo forte era il rock dal vivo, con una band che aveva tutti i numeri per sfondare nell’affollato e variopinto panorama del progressive italiano: MAB, Minestra Affogata in Brodo. L’acronimo MAB parafrasava ironicamente quello del celebre Moschetto Automatico Beretta, in uso presso le Forze Armate, a sottolineare alcuni must dell’epoca come il pacifismo e la pace universale. La frontline del gruppo: Michele Bianchini (basso e flauto, frontman e mente creativa), Angelo Bianchini (batteria, prematuramente scomparso), Rino Colonna (chitarra), tre musicisti di alto livello limitati solo dalla distanza dal triangolo d’oro del rock italiano (Roma, Milano, Bologna). Ma il Giangià schierava addirittura due rock-band: l’altra fu battezzata col suggestivo nome di Pericolo Astratto di un Esperimento Riuscito, un nome che per concepirlo non sarebbe bastato fumarsi tutte insieme le aiuole della Villa Garibaldi. Ma all’epoca usava così, era una gara a chi la sparava più grossa….che tenerezza. Frontline: Pino Semeraro e Raffaele Marangi (chitarre), Antonio Napolitano (percussioni), Stefano Campanella (basso). Membri occasionali: Mimmo Diamante e Pino Simone. Pino era un artista totale (poeta, pittore, outsider e musicista) ma all’epoca non comprendemmo il suo reale valore. Con i due gruppi, con la loro musica d’avanguardia, il Giangià fu un punto di riferimento per l’Italia meridionale che vantava rari capisaldi tra Bari e a Napoli. Giangià Club era ormai sinonimo di uno stile di vita, un mainstream che contagiava tutto l’ambiente cittadino surriscaldato da intellettuali, nel nostro caso Nico Blasi, che accompagnavano la transizione di una scoppiettante comunità dall’economia agricola alla giacchetta made in Martina sullo sfondo delle poco rassicuranti sagome degli altoforni italsiderini. Nei primi anni ’70 Nico Blasi si rese protagonista di una operazione culturale che si richiamava direttamente alle famose cantine dell’avanguardia teatrale romana capitanata da Carmelo Bene. La cantina martinese si chiamava C.A.T.I. (Centro Artistico Teatrale Incontro), situata di fronte all’attuale farmacia di Pasquale Mega in via Lelio Fanelli. La gemma più pura fu la rappresentazione, per la regia-adattamento dello stesso Nico, di Escurial dell’autore fiammingo Michel de Ghelderode. Proprio niente da invidiare alle capitali della cultura italiana dell’epoca. Il giro era sempre lo stesso della galassia Giangià , con Raffaele Agrusta e Gerardo Martino attori nei ruoli de Il Re e Folial, e Pino Semeraro (da non confondere con l’assessore socialista degli anni 90), autentico uomo-quercia martinese nei panni, anzi senza panni perché recitava seminudo, di Uto il boia…. Non ci facevamo mancare niente, nemmeno il cinema che oggi definiamo indipendente. Il lungometraggio Edipo, regia di Nico Blasi – sceneggiatura di Dino D’Arcangelo, fu girato con attori e comparse del giro Giangià e non era affatto male nonostante le condizioni economiche quarto-mondiste della produzione (altra caratteristica delle operazioni dell’epoca). Senza offesa per nessuno, credo che la grande vitalità culturale dell’odierna Martina si debba anche all’azione rivoluzionaria di quel periodo cui contribuirono personaggi indimenticabili del calibro di Dino D’Arcangelo, dotato di una visione culturale un milione di anni luce avanti a tutti noi. Autentico genio della comunicazione, prima di approdare alla grande stampa nazionale Dino lasciò a Martina un’eredità immensa, il cui valore solo oggi ci è dato comprendere appieno. Catalizzava energie ovunque mettesse le mani. Quando nel 1975 Raffaele Agrusta fondò con Gerardo Martino la mitica Radio Farfalla (la seconda emittente privata in Italia!) Martina era già un laboratorio culturale di prim’ordine e Dino intuì immediatamente le potenzialità del formidabile mezzo. Collaborò con pagine magistrali di cultura radiofonica come Spegni la Radio, capolavoro di non-sense con Gerardo e Lino Panico, altro personaggio mitico dell’epoca. Approdato alla Repubblica, Dino si impose curando rubriche musicali e di costume che hanno fatto epoca, era ormai il guru nazionale del famigerato popolo della notte. Verso la fine degli anni ’70 il movimento hippy e il maggio francese avevano esaurito la loro spinta storica e la generazione Giangià , che ormai annoverava 20-25enni, si trovava spiazzata e senza punti di riferimento culturale. Il terrorismo delle Brigate Rosse era passato alla propaganda armata decapitando i sogni, forse un po’ ingenui ma autentici, di una sub-cultura giovanile che si avviava al punk per un verso e alla disco-music per l’altro. E arrivavano i fricchettoni-indiani metropolitani che su musica, teatro, filosofia e spiritualità non avevano alcun punto di contatto con le generazioni precedenti. Ma è stata comunque una bella Martina quella dei 70-80: un distillatore in perpetuo stato di bollore che secerneva talento e voglia di futuro, che offriva un’occasione a chi la cercasse ed era capace di esaltare anche i suoi figli fuori sintonia rispetto alla propria natura capacchiona e pragmatica che bada al sodo e mette al bando le puttanate…. Un grande popolo, senza dubbio!
Â
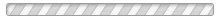

 Pubblicato da:
Pubblicato da:  Categoria: EVENTI
Categoria: EVENTI

