Non sembrerebbe, ma la memoria riguarda più il futuro che non il passato, capace com’è di costruire, ricostruire e proiettare. Nel saggio di Francesco Paolo Romeo tutto su questa “bussola retrospettiva"
"La memoria è il più grande strumento mentale a disposizione dell'uomo, è una pietra smussata per scavare nel terreno in cerca di tuberi, una lancia per cacciare, un suono per comunicare, una lingua per divulgare, un foglio di carta su cui scrivere e fissare. Attraverso la memoria guardiamo indietro nelle nostre esperienze e poi avanti quando ne progettiamo di nuove; cogliamo gli insegnamenti del passato per metterli a disposizione del futuro. La memoria è una ‘bussola retrospettiva’ che fa emergere e orientare i nostri processi decisionali”.
Così scrive l’autore Francesco Paolo Romeo, nel suo libro “La memoria come categoria pedagogica”. Il testo racchiude la ricerca dello studioso e mira a dimostrare come la memoria sia una bussola autobiografica e sociale attraverso la quale scegliere una prospettiva, individuare un orientamento, seguire una direzione. Francesco affronta sapientemente il tema della memoria, esplorandone i segreti e le matrici di significato con un approccio finora poco conosciuto e utilizzato nella letteratura pedagogica. Spesso infatti siamo portati a pensare alla memoria come una funzione cognitiva individuale, statica e retrospettiva, tanto da rappresentarla generalmente con le immagini di un contenitore da riempire con i ricordi più importanti della nostra vita, essa invece ha a che fare più con il nostro futuro e con quello delle comunità cui apparteniamo. La memoria è una sorta di mappa per orientarsi tra passato, presente e futuro, essa custodisce il passato e tende al futuro, progettandolo e rielaborandolo sulla base delle esperienze già vissute come singoli e come collettività.
La memoria, come del resto sostiene Yourcenar, è la storia commentata dell’esperienza dell’uomo per costruire e ricostruire collaborando con il tempo nel suo aspetto di passato, cogliendo lo spirito e modificandolo, proiettandolo quasi verso un più lungo avvenire: significa scoprire sotto le pietre il segreto della sorgente. Senza la memoria non esiste scansione storica, né identità, né possibilità di dare senso alla propria vita individuando radici, matrici di significato in ciò che è accaduto, agli eventi della storia individuale e collettiva che hanno generato il nostro essere così come siamo oggi. Il testo intende offrire originali risposte sull'opportunità di considerare la memoria come categoria pedagogica, dunque come un dispositivo educativo di riconoscimento, posizionamento e orientamento del Sé, perché progettarsi resta un compito educativo permanente, volto ad attuare nell'individuo una perfetta sintesi tra memoria del passato e intenzionalità e propensione verso il futuro.
Francesco Paolo Romeo ci ricorda che costruire memoria e identità deve rappresentare una finalità educativa sulla quale lavorare, consapevoli di stare dentro una Storia fatta di molte storie che possono aiutare a progettare il futuro attraverso originali ed innovative traiettorie, attraversando le storie di vita di chi ha vissuto sulla propria pelle esperienze spaesanti e nonostante tutto ha cercato di costruire il proprio futuro.
Molte sono le molte domande alle quali il testo offre originali risposte: è possibile educare alla memoria individuale e collettiva riconfigurando le narrazioni delle esperienze passate come potenti dispositivi di riconoscimento, posizionamento e orientamento del Sé e delle comunità? Nel momento in cui le narrazioni del passato risultassero ancora "in cicatrizzazione", perché collegate ad esperienze spaesanti che hanno disorientato l'esistenza di individui e comunità, come è possibile lavorare sugli snodi della memoria per renderli sostenibili aumentandone i gradi di libertà progettuale? Queste e tante altre domande sono trattate in modo esemplare sviluppando argomenti che interessano studenti universitari e quanti operano nel sociale.
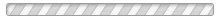


 Pubblicato da:
Pubblicato da:  Categoria: CULTURA
Categoria: CULTURA
